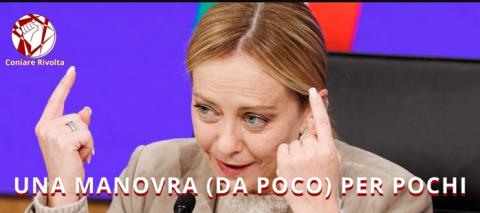16/11/2025
Che la manovra di bilancio per il 2026 sarà l’ennesima manovra all’insegna dell’austerità è noto e conclamato. Ancora non completamente definiti sono, invece, i suoi aspetti qualitativi, ovvero la composizione delle entrate e delle uscite previste per il prossimo anno. Mentre stanno emergendo in questi giorni elementi via via più evidenti (e inquietanti) sui tagli alla spesa, sembrano ormai definiti, salvo ritocchi finali, i pilastri delle voci in entrate, ovvero gli aspetti tributari della legge di stabilità.
Il governo li sta presentando come un blocco di misure coraggiose che alleggerirebbe il fardello fiscale sugli italiani e in particolare sul ceto medio. Tuttavia nelle recenti audizioni parlamentari perfino Bankitalia, l’Ufficio parlamentare di Bilancio e Istat si sono espresse criticamente rispetto agli aspetti quantitativi e qualitativi della manovra definendola “modesta” e “redistributiva in senso regressivo”.
Proviamo ad analizzare gli aspetti principali del “lato entrate” della finanziaria inquadrandoli nel contesto generale delle politiche tributarie e delle scelte distributive degli ultimi decenni.
La misura di cui si è più discusso è la riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF, quella che colpisce la quota dei redditi da 28.000 a 50.000. Ricordiamo che l’attuale struttura dell’imposta sui redditi in Italia ha ormai ridotta a solamente tre aliquote: 23% da 0 a 28.000 euro; 35% da 28 a 50.000, 43% oltre i 50.000. La seconda aliquota passerebbe così dal 35% al 33%, riduzione eliminata per chi dichiara un reddito superiore a 200.000 euro. Il beneficio massimo, 440 euro di risparmio di imposta, spetterebbe a chi ha redditi compresi tra 50.000 e 200.000 euro. Questo effetto è dovuto alla logica degli scaglioni, dove il vantaggio in termini assoluti è di chi ha dai 50.000 in su poiché gode della riduzione nell’intero arco di tutta la capienza dello scaglione. Dall’altro lato il governo, forse per pudore, ha sterilizzato la manovra dai 200.000 in su, con quindi in questo caso nessuna diminuzione di aliquota, ma con il rischio di incentivare l’evasione attorno a quella soglia. Secondo ISTAT l’85% delle risorse destinate a questa misura vanno a vantaggio dei 2/5 più ricchi delle famiglie italiane. Si riduce insomma la tassazione sui lavoratori, ma principalmente per i redditi più alti, in quello che è solo l’ennesimo tassello verso l’erosione della progressività.
Le disuguaglianze economiche in Italia, come in gran parte dei paesi del mondo occidentale, sono via via peggiorate negli ultimi 30 anni. Non soltanto è peggiorata la distribuzione tra salari e profitti e tra salari bassi e salari alti, ma che il sistema tributario ha via via rinunciato alla propria missione costituzionale (art. 53) di vettore di redistribuzione delle risorse economiche dall’alto al basso. In altri termini la progressività delle imposte si è drasticamente ridotta a partire dalla seconda metà degli anni ’80, non solo attraverso la riduzione delle aliquote (dalle 32 del 1974 alle sole 3 di oggi) e l’assottigliamento della distanza tra redditi minimi e massimi compresi negli scaglioni, ma anche e ormai soprattutto tramite la fuoriuscita di una parte consistente dei redditi diversi dal lavoro dipendente (a iniziare di quelli da capitale) dall’assoggettamento all’imposta sui redditi delle persone fisiche con la previsione di regimi separati più favorevoli e non progressivi.
Un meticoloso (e ben riuscito) progetto di distruzione della giustizia tributaria, perseguito da tre decenni dai governi di turno, di ogni colore, a favore del capitale e dei ricchissimi e a danno di lavoratori e redditi medi.
Stonano davvero, allora, le voci indignate dei partiti di opposizione, artefici assieme ai partiti di governo del sistema tributario attuale, che criticano le modifiche dell’IRPEF in quanto “avvantaggerebbero i più ricchi”.
La verità è che in un sistema così strutturalmente iniquo di cui non si discutono mai i fondamenti, i termini del dibattito e le misure di aggiustamento, restano al più centrati su aspetti secondari e superficiali rispetto alle violazioni equitative profonde dello status quo.
In questo contesto di generale parcellizzazione e scarsa significatività degli interventi, del resto, vanno interpretate anche le altre tre misure previste dalla Legge di bilancio in tema di tributi sul reddito delle persone fisiche.
In primo luogo, la detassazione degli aumenti di stipendi legati a rinnovi contrattuali. Questi ultimi, per un solo anno dopo il rinnovo e comunque solo per chi ha redditi fino a 28.000 euro, verranno tassati al 5% e non con l’aliquota marginale del proprio reddito. Un piccolo sollievo per i redditi più bassi, per di più temporaneo di due soli anni. E per quanto si siano alzate opinioni positive, appare più come l’ennesimo tentativo di far pagare alla fiscalità generale, e non ai padroni, gli aumenti dei salari minimi.
In secondo luogo, la revisione dell’aliquota sugli affitti brevi. Come noto, i redditi da affitto immobiliare sono esclusi dalla base imponibile IRPEF per una legge risalente al 2010. Ad oggi l’aliquota, cedolare secca non progressiva, ammonta al 21% con un valore che scende al 10% nelle grandi città per i canoni concordati (che comunque sono tutt’altro che bassi). In un disegno caotico e pieno di contraddizioni, fanno ancora eccezione gli affitti ad uso commerciale che, a differenza di quelli ad uso domestico, soggiacciono all’imposta sui redditi progressiva. In questo disegno, nel 2023, venne introdotta una norma che portava l’aliquota dal 21% al 26% per le locazioni brevi (ovvero gli affitti di durata inferiore ai 30 giorni consecutivi), ma soltanto dalla seconda casa locata in su. Il reddito da affitto di un’unica casa in locazione breve restava invece assoggettato all’aliquota del 21%. La legge di bilancio ora porterebbe, dal 2026, l’aliquota al 26% anche per la prima casa locata, ferma restando l’aliquota del 21% in caso di affitto senza intermediazione digitale (un caso residuale per gli affitti brevi regolarmente dichiarati visto che oltre il 90% delle locazioni brevi passa per le note piattaforme digitali).
La discriminazione tra trattamento tributario dell’affitto breve rispetto a quello stabile ha naturalmente il senso di disincentivare l’uso delle case per affitti turistici in un mercato immobiliare in cui il diritto all’abitare per persone e famiglie meno abbienti è continuamente leso da prezzi elevatissimi e da scarsità degli alloggi disponibili.
Tuttavia, la norma, insufficiente di fronte a una crisi abitativa dilagante, non tocca in alcun modo le contraddizioni di fondo di un sistema tributario che sottrae alla progressività delle imposte i redditi da uso del capitale immobiliare e finanziario tramite cedolari proporzionali e agevolate. Rimane evidente una paradossale discriminazione tra redditi da lavoro e parte dei redditi di capitale per cui la stessa quantità di reddito (immaginiamo 50.000 euro lordi annui) subisce una tassazione molto più pesante se proveniente dal lavoro. Viene quindi creata una totale assenza di meccanismi progressivi all’interno degli stessi redditi da capitale mettendo sullo stesso piano entrate fortemente differenziate.
La terza misura, di scarso rilievo quantitativo, riguarda un ritocchino sul cosiddetto regime rimpatriati introdotto dal governo Renzi nel 2014. Secondo tale norma chi sposta la residenza fiscale dall’estero all’Italia paga nel nostro paese le normali imposte per il reddito prodotto all’interno delle nostre frontiere, mentre per tutti i redditi prodotti altrove (che, essendo fiscalmente residente in Italia, dovrebbero comunque essere assoggettati a tassazione) paga un’imposta forfetaria di 100.000 euro, peraltro senza obblighi di dichiarazione di sorta (per cui i redditi esteri restano di fatto ignoti). L’attuale governo ha innalzato l’imposta forfettaria da 100.000 prima a 200.000 nel 2024 ed ora a 300.000. Al di là del migliorativo aumento dell’asticella, resta la conferma di una misura indegna che descrive in modo plastico lo scandalo della concorrenza fiscale sui grandi capitali e gli alti redditi che sottrae gettito ad altri Stati promettendo paradisi di trattamento differenziato innescando una corsa al ribasso a vantaggio dei ricchi e a discapito dei gettiti fiscali nazionali. Da quest’anno, peraltro, si esaurisce un simile regime nel Regno Unito e paesi come l’Italia che lo mantengono approfitteranno di un significativo aumento della platea potenziali di capitali in fuga.
In ultimo, l’iniquità più grande dal punto di vista fiscale non sta nelle varie misure fin qui descritte, ma in quello che non c’è, ovvero il recupero del cosiddetto fiscal drag. Si tratta di quell’aumento delle imposte che si verifica nei periodi di alta inflazione (come il biennio 2022/23) cui segue un periodo di rinnovo dei contratti. Come abbiamo detto in passato, in particolare in Italia questi rinnovi sono avvenuti per cifre al di sotto dell’inflazione, determinando una perdita di valore dei salari reali. Tuttavia, quel piccolo aumento dei salari nominali (su cui ovviamente si computano le tasse) ha comunque determinato una perdita delle detrazioni e/o un passaggio agli scaglioni di reddito imponibile superiori, generando così un aumento delle imposte pagate anche se i salari reali diminuivano. A quanto ammonta questa perdita dovuta al drenaggio fiscale? Qui le cifre impazzano: i sostenitori delle misure varate dal governo in questi anni sottolineano che si tratterebbe di una cifra modesta, considerati i vari interventi fiscali introdotti in questi anni (che però, va ricordato, avevano una finalità diversa, per quanto anch’essa discutibile, ovvero la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale). Stime più realistiche, su cui peraltro convergono sia la CGIL che insospettabili economisti di area liberista, valutano tale impatto di drenaggio a ben 25 miliardi. E’ evidente che un vero intervento di restituzione avrebbe richiesto l’indicizzazione automatica dei vari parametri fiscali, ovvero la revisione al rialzo delle soglie usate per gli scaglioni e/o per le detrazioni, ma di tutto questo nella manovra (e nelle scorse manovre) non vi è stata traccia.
In conclusione, le misure tributarie del governo in tema di imposte sui redditi risultano totalmente allineate con le tendenze degli ultimi anni mostrando ben poche novità significative. Un governo che ha nelle sue corde ideologiche e nei suoi proclami esplicitati in campagna elettorale il liberismo fiscale e tributario fondato sull’appiattimento della progressività (fino all’obiettivo più volte declamato di una flat tax sui redditi) e la detassazione dei redditi da capitale, di fatto al terzo appuntamento con la manovra non introduce alcun cambiamento sostanziale nella struttura dei tributi in Italia.
I motivi di questa sostanziale continuità risiedono essenzialmente in due fattori.
In primo luogo, il sistema tributario italiano è già stato stravolto in senso liberista e regressivo in tre decenni di controriforme che hanno reso la struttura dei tributi sempre più iniqua, sempre più parcellizzata, sempre meno universale e sempre meno redistributiva. In secondo luogo quand’anche un governo volesse imprimere un’ulteriore accelerazione liberista al sistema tributario, si scontrerebbe con la logica dell’austerità fiscale ripristinata in pieno dal 2023-2024 dopo la breve parentesi della fase pandemica che mentre impone tagli della spesa riducendo il ruolo dello Stato nell’economia allo stesso tempo non consente repentine diminuzioni delle entrate (soprattutto sulle fasce di reddito più rappresentative) dando luogo così ad un mix micidiale di liberismo e significativa pressione tributaria sui ceti medio-bassi che oltre ad esasperare le disuguaglianze produce recessione (o crescita stentata) e disoccupazione (o cattiva occupazione).